di Federico Stoto
Viaggiando in solitudine per i cinema di provincia a bordo di un furgone, i due protagonisti del film di Wenders cercano forse di realizzare una condizione di radicale libertà dal tempo. Ma nel tempo si ritrovano inesorabilmente a ricadere, dimostrando come esso sia, con la dose di dolore e speranza che implica, la condizione essenziale dell’esistenza umana.
L’idea di scrivere qualcosa oggi su Nel corso del tempo, l’ultimo film della trilogia della strada di Wim Wenders, uscito nel 1976, non nasce dall’intento di collocarlo nel quadro di una storia del cinema, o magari nel quadro di una storia del cinema di Wenders, né tantomeno dalla volontà di evidenziare in esso il discorso critico sul cinema dell’epoca che il regista sviluppa, vedendolo così come una sorta di cinema sul cinema, né infine da un interesse di tipo storico per la Germania ancora divisa, che è costantemente sullo sfondo della pellicola.
Tutti questi aspetti sono indubbiamente di grande interesse ma, oltre ad essere già stati sicuramente analizzati, non rientrano nell’ambito di competenza di chi scrive. Il tentativo che si cercherà di fare è, invece, quello di parlare, tra i vari temi che in questo film si sovrappongono, di quello che potremmo definire esistenziale, ovvero di quel discorso sull’uomo e sui suoi problemi, che ci risulta senza dubbio più attuale e ancora capace di interpellare direttamente noi uomini di oggi.
La trama del film è presto detta: un uomo, Robert, tenta il suicidio schiantandosi dentro un fiume con la sua macchina, ma il tentativo non riesce e si salva. Nuota fino a riva e uscendo dall’acqua si ritrova in prossimità del furgone di Bruno. Bruno è un proiezionista che ha fatto di questo furgone la sua casa e viaggia per cinema di provincia riparando macchine da presa. Bruno in qualche modo si sente chiamato a dover prendere Robert con sé e prosegue insieme a lui per vari giorni il suo viaggio in furgone di cinema in cinema.
Partiamo ora però dalla fine. In uno degli ultimi dialoghi del film Robert racconta a Bruno che, nel suo lavoro di psicolinguista, si occupava in particolare dell’apprendimento della scrittura nei bambini. Egli ha notato che prima di imparare a scrivere i bambini si muovono in un mondo in cui i numeri e le lettere sono ancora delle avventure, e dice che «c’era un bambino per cui le lettere erano come strade, dove le lettere arrivavano grazie ad una motocicletta, la penna». Ascoltando queste parole, dopo quasi tre ore davanti allo schermo, si ha la sensazione che i bambini a cui in realtà ci si riferisce siano gli stessi Robert e Bruno. E infatti, per tutta la durata del film, i due si muovono su un furgone attraverso le strade parlandosi pochissimo. Le parole che si dicono sono poche e spesso vuote e l’attenzione della macchina da presa è spostata sul mondo che li circonda, che da sfondo diventa esso stesso protagonista.
È una scelta, questa, che all’inizio può risultare straniante agli occhi dello spettatore, che è abituato a vedere sullo schermo dialoghi e avvenimenti, piuttosto che tutta questa quiete. In particolare, viene in mente la scena in cui i due prendono in prestito proprio una motocicletta (la penna) e vanno in giro felici indossando dei buffi occhiali trovati per caso, e potrebbero essere proprio quegli occhiali a simboleggiare lo sguardo bambino che viene prima delle parole e ai cui occhi tutto è ancora avventura.
Bruno e Robert, viaggiando insieme con quel furgone, hanno quindi tacitamente deciso di ripartire da zero e mettere tra parentesi tutto ciò che li potrebbe espropriare da loro stessi, come li esproprierebbero il tempo e il linguaggio, approdando ad una zona in cui regna il silenzio dell’immediato presente. Per cui vivono alla giornata, praticamente in solitudine, senza farsi troppe domande e senza stare a raccontarsi il loro passato. Ma la vita è strutturalmente espropriazione, è abitata dall’Altro, e i bambini possono vivere in quella condizione forse perché in realtà non hanno ancora davvero vissuto. Di fatti anche il loro stato di grazia non è destinato a durare in eterno


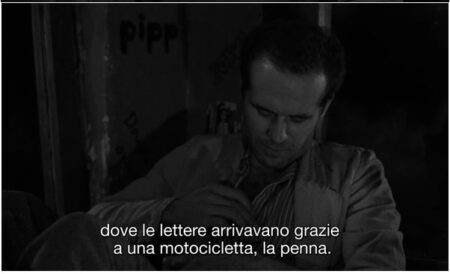
poiché, come continua a spiegare Bruno, i bambini che si attardano in quello stato sono destinati a sviluppare dei disturbi dell’attenzione.
L’impossibilità di vivere una condizione di totale libertà ed indipendenza esistenziale non tarda a mostrarsi anche per i nostri protagonisti ed inizia ad emergere, per esempio, quando Robert, per parlare della sua professione, ritorna alla storia di sua moglie a Genova. Ma Bruno lo ferma e gli dice «ti ho chiesto solo che professione fai, non devi raccontarmi la tua storia», opponendosi quindi subito a qualsiasi discorso che invochi il passato. Robert ribatte però dicendo: «io sono la mia storia», dimostrando così l’impossibilità di cancellare del tutto il suo passato.
La prima vera scena del film in cui però la condizione di totale libertà, indipendenza e incolumità di fronte a ciò che non è dominabile, propria dei protagonisti, esplode è quella in cui enigmaticamente, mentre i due dormono nel furgone, compare durante la notte un uomo disperato, la cui moglie si è appena andata a schiantare contro un albero con la macchina. Traumatizzato e in stato confusionale, quest’uomo riesce a dire solo frasi sconnesse. È in preda alle lacrime e al dolore di fronte a un evento che non si sa spiegare, che non vorrebbe doversi spiegare.
È l’eterno mistero della morte, che irrompe sulla scena e che lo espropria totalmente. L’unico modo in cui riesce a reagire è negandone disperatamente l’evidenza: «eppure esiste solo la vita» dice, «la morte non esiste» e, intanto, la piange. È questa forse una delle scene più potenti del film, perfettamente realizzata e in cui la colonna sonora gioca un ruolo determinante. È utile a questo punto ricordare le parole di Emmanuel Levinas secondo cui «l’ignoto della morte significa che la relazione con la morte non può accadere nella luce; che il soggetto è in relazione con ciò che non viene da lui. Potremmo dire che è in relazione con il mistero».[1] C’è allora un’alterità, di cui la morte è una cifra, che strutturalmente ci abita, e che per quanto ci impegniamo non riusciremo mai definitivamente ad espellere.
Ma se l’espropriazione è manifestata in modo concentrato ed icastico nella scena raccontata sopra, essa è in realtà un tema che affiora via via, in modo sempre più evidente lungo il film, anche direttamente in relazione alla vita dei due protagonisti. Al loro tentativo di alleggerirsi di ogni peso, di vagare liberi e senza legami, si contrappongono scene in cui vengono – per così dire – tirati verso il basso. Robert infatti non smette mai di provare, di tanto in tanto, a telefonare a sua moglie. Si capisce ad un certo punto che la questione è torbida, probabilmente ha commesso degli atti di violenza su di lei e nel dialogo finale, quando Bruno gli chiede il motivo di queste telefonate, risponde: «perché ho paura che le succeda qualcosa». È un legame, esacerbato dal senso di colpa, che Robert non può fino in fondo cancellare. D’altronde, proprio provando a parlare della moglie, aveva riconosciuto che lui è la sua storia.
Bruno invece sembra essere, tra i due, quello che meglio è riuscito a fare della totale libertà e indipendenza la sua condizione di vita. Viaggiando con il suo furgone vive, infatti, solo con lo stretto indispensabile e sembra che non sia davvero legato a nessuno. Ma la sua condizione è talmente radicale che assume i tratti del patologico. Robert, non a caso, sempre in quel determinante dialogo finale, paragona il suo furgone ad un bunker, e la sua vita a quella di un morto, in cui è scomparso ogni desiderio. Non è esagerato dunque vedere in Bruno anche l’inibizione propria del nevrotico che, usando le parole di Massimo Recalcati, «coltiva una passione patologica per il limite».[2] E, in effetti, è proprio come un nevrotico che Bruno viene ritratto da Wenders quando si infuria perché Robert inavvertitamente rompe il vasetto con l’acqua che stava usando per farsi la barba, vasetto che è uno dei pochi oggetti della vita nel furgone ossessivamente ridotta all’estremo essenziale (anche la maglietta sotto la salopette è superflua per Bruno).
All’accusa di essere un morto Bruno risponde che in realtà lui desidera ogni donna, ma il problema è che non riesce a convivere col fatto di doverne scegliere una, e sapere, contemporaneamente, che potrebbe essere diversa da come è. Egli vorrebbe «essere una cosa sola con una donna» e contemporaneamente «essere solo con sé stesso». È un eterno problema quello di Bruno, perfettamente reso per esempio nelle pagine di Emil Cioran: «se fossimo in grado di sottrarci ai desideri, – dice Cioran – ci sottrarremmo nel contempo al destino; superiori agli esseri, alle cose e a noi stessi, restii ad amalgamarci di più con il mondo, attraverso il sacrificio della nostra identità accederemmo allora alla libertà, inseparabile da un allenamento all’anonimato e alla rinuncia. “Io non sono nessuno, ho vinto il mio nome!” esclama colui che non volendo più abbassarsi a lasciare traccia di sé cerca di conformarsi all’ingiunzione di Epicuro “Nascondi la tua vita”».[3]



Non è un caso che il titolo del libro di Cioran appena citato sia La caduta nel tempo, perché è proprio dal tempo che i protagonisti del film di Wenders cercano forse di fuggire, viaggiando con il loro furgone attraverso i cinema di provincia. Tempo inteso come cifra definitiva della finitezza umana. Ma tempo in cui, anche, fatalmente, ricadono – poiché esposti, in quanto esseri umani, all’impossibilità di essere nessuno. Impossibilità che porta necessariamente con sé il dolore della morte, del rimpianto e della speranza. Wenders non dà risposte, si limita a descrivere il dramma, facendo dire a Robert che «bisogna sopportare questa contraddizione». Ce lo ricordava anche Carlo Michelstaedter, sulle cui parole è posata una tragica amarezza: «né alcuna vita è mai sazia di vivere in alcun presente, ché tanto è vita, quanto si continua, e si continua nel futuro, quanto manca del vivere. Che se si possedesse ora qui tutta e di niente mancasse, se niente l’aspettasse nel futuro, non si continuerebbe: cesserebbe d’esser vita».[4] A continuare i protagonisti proveranno, dopo essersi lasciati con un biglietto su cui Robert aveva scritto che era il momento “di cambiare tutto”.
__________________
[1]E. Levinas, Il Tempo e l’Altro, Il melangolo, Genova 1987, p.41.
[2]M. Recalcati, Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, Milano 2016, p. 31.
[3]E. M. Cioran, La caduta nel tempo, Adelphi, Milano 2018, p. 38.
[4]C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Adelphi, Milano 2018, p. 40.






