
Pubblicato il 22 Luglio 2021.
Quello che segue è un estratto dal saggio Viaggio al termine del Novecento. Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, pubblicato dall’Accademia del Cinema UniARES il 16 luglio in occasione del ventiduesimo dall’uscita del film. Il libro, a firma di Ludovico Cantisani, studioso di cinema e filosofia, contiene una prefazione di Umberto Cantone, dei disegni originali di Elisa Terranera e un’intervista esclusiva ad Emilio D’Alessandro, autista di Kubrick già protagonista del premiato documentario S is for Stanley – Trent’anni dietro al volante per Stanley Kubrick. Il volume è disponibile in formato ebook su Amazon e a breve, in formato cartaceo, nelle migliori librerie.
L’uscita del suo film negli ultimi mesi dell’ultimo anno del Novecento doveva solleticare non poco Stanley Kubrick. Irripetibile occasione di concludere un secolo e anzi un millennio, in attesa di quel 2001 che un tempo era sembrato quanto mai adatto ad assistere a un’Odissea nello Spazio. Eppure Eyes Wide Shut appare ancora ordinato, nel suo raccogliere a “spugna” tutti i suoi archetipi, pregio che alcuni di quanti, tra i film a venire del Duemila, tenteranno ancora la via che porta ad essere “opere-mondo”, non avranno. In quell’“è difficile” – anzi, secondo alcune traduzioni, del tutto “pericoloso” – “essere eredi” che ex abrupto veniva a sconvolgere la prosa già visionaria dell’Also sprach Zarathustra nietzschiano si trovava non solo una ricapitolazione anticipata di tutto il Novecento – il Novecento come meditata iconoclastia, a voler semplificare, nel rifiuto di una tanto pesante e millenaria eredità – ma anche una prefigurazione della parziale stagnazione che, a Novecento finito, si è venuta a creare nel mondo dell’arte e della cultura tutta.
Abbiamo abbondantemente visto come in Eyes Wide Shut ritornino molti, forse troppi echi con la letteratura novecentesca, e, in misura minore, anche con alcuni film precedenti di altri autori. Ritorna Schnitzler, ritorna Joyce, si avvertono somiglianze con Proust, si possono operare confronti con Salinger, o con lo stesso Roth: così come alla letteratura del novecento appartenevano anche i testi di Frazer e di Freud. Eyes Wide Shut assomma in sé certe suggestioni dell’Antonioni de La Notte, lo abbiamo visto, e forse dell’Ophüls de La Ronde, ma si avverte anche qualcosa di Fellini e, benché il suo regista appartenesse alla “generazione successiva”, Roger Ebert ha fatto notare delle analogie anche con After Hours di Martin Scorsese, datato 1985. Ogni scena riprende e fa la parodia degli stilemi del genere erotico-pornografico: ma al tempo stesso Kubrick guardò con interesse – anche per vedere fin dove potesse spingersi mantenendosi all’interno del visto censura R – alcuni thriller erotici di fine anni ottanta-primi anni novanta, come Basic Instinct di Paul Verhoeven e 9 settimane e mezzo di Adrian Lyne, la cui coppia protagonista Mickey Rourke-Kim Basinger fu brevemente considerata da Stanley per quello che sarebbe diventato Eyes Wide Shut. Uno dei punti caratterizzanti di Eyes Wide Shut è però il fatto che, malgrado tutti questi echi e tutti questi parallelismi, tanto a un livello strutturale quanto a un livello narrativo quanto a un livello visivo resta un film di un’originalità placidamente radicale.
Non è però la citazione più o meno sfumata di alcuni dei più grandi romanzi e autori novecenteschi, e neanche l’eco in sé e per sé di questi testi ed extratesti, a rendere Eyes Wide Shut così maledettamente riassuntivo di un intero secolo. Evitando per amor di brevità di considerare che più che un Novecento ce ne furono almeno tre – un Novecento storico, un Novecento psicologico e un Novecento artistico-letterario – quel che è certo è che Eyes Wide Shut coglie il Novecento come esitazione, come promessa forse poi non del tutto mantenuta. L’apologo della corsa allo spazio forse ha un valore collettivo-esistenziale più ampio del previsto, e non può essere un caso se Stanley Kubrick, che nel 1968 immaginava un 2001 in cui i viaggi spaziali sarebbero diventati quasi quotidiani, nel 1999 riambientava le sue vicende in un presente stantio, la cui eleganza, delle strade e delle ville e delle luci al neon, altro non è che una profilassi di una disperazione crescente.
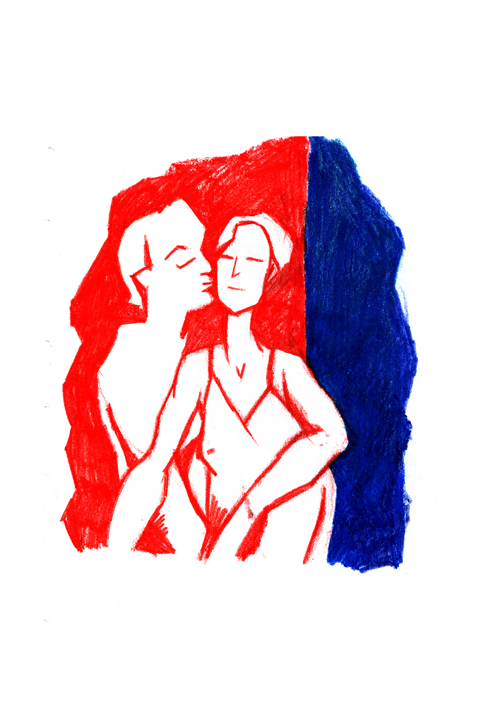
Disegno originale © Elisa Terranera
Il Novecento come esitazione, dunque, nel progredire cartesiano-nevrotico di una Kubrickology che in Eyes Wide Shut trova i suoi accenti più personali e più meditati. Molto più che nel cosmologico e quasi metafisico 2001, con Eyes Wide Shut Kubrick va ad indagare le “cose ultime” se non i principi primi della vita sulla terra, della vita in società, della famiglia e del matrimonio: il principio che regge il mondo, questo mondo, non ha più nulla di celestiale, teologico o extraterrestre che sia, ma ha un fondo maledettamente pulsionale. O meglio, forse il vero principio strutturante del mondo, posto che ce ne sia uno solo, è proprio la dialettica tra la pulsione e il suo “debutto in società”, tra la pulsione e la sua compromissione, che non è repressione come voleva Marcuse, resa necessaria dal contatto con altri esseri umani, dalla permanenza in una comunità sociale.
Nel Novecento letterario, l’autore che meglio di tutti seppe trattare, con fare assolutizzante, questa dialettica non fu né Arthur Schnitzler né James Joyce, bensì Franz Kafka – l’ennesimo scrittore ebreo che incontriamo indagando Eyes Wide Shut, per inciso. Soprattutto nella scena del processo, la “scena madre” di Eyes Wide Shut, non è affatto difficile cogliere i tratti del kafkiano, di quel kafkiano su cui Deleuze e Guattari avevano speso alcune delle migliori pagine della loro produzione a quattro mani. Gli stessi dialoghi, della cui macchinosità si pentiva Michael Herr tardivamente chiamato a fare da script editor al duo Kubrick-Raphael, presentano un tono, una lentezza e un continuo bisogno da parte del protagonista di chiarimenti che direttamente può essere fatto risalire alla prosa kafkiana. L’esitazione, l’impasse come fatto esistenziale, la violazione di una regola – di una Legge – priva di contenuto, la struttura accerchiante e accerchiatrice del complesso degli uomini, ai danni di un singolo individuo che, nella sua contingenza e nella sua banalità qui di medico e lì di impiegato, si trova davanti al dispiegarsi di un abisso privato di senso. Ciò che, per vie diverse ma parallele, i protagonisti dei tre romanzi di Kafka e il Bill Hartford schnitzler-kubrickiano scoprono, è proprio questo: un abisso privato, un ristagnare clandestino di una “zona d’ombra” entro cui le strutture alla base della nostra società emergono in viva forza, a mo’ di fatti bruti, dove ogni rappresentazione scende al grado zero della propria significazione. Eppure, eppure – un tale abisso, la cui portata ermeneutica sarebbe da sola capace di smontare sin dalle fondamenta un’intera civiltà, deve restare privato. Messaggero senza messaggio, Bill Hartford deve ridursi al silenzio, e lo fa col sorriso fra le labbra, smanioso di riconquistare certezze perdute: più semplicemente, Kafka non conclude, e, nel carattere senza-fine dei suoi tre romanzi, si ritrova proprio quella cattiva infinità che permette alla nostra società e alla civiltà tutta di perpetuarsi senza soccombere alle sue rare apocalissi, di senso o di scopo.
Non possiamo però limitare il kafkiano alla presa d’atto romanzesca dell’impossibilità di una fine e di una trasmissione: cruciale in Kafka è anche un discorso sulla responsabilità, su una responsabilità schizzata che diventa un po’ un “tutto contro tutti”, un po’ uno “stallo alla messicana”. Ciò si vede in modo particolare ne Il processo, con un ignaro e sempre più straniato Joseph K. portato alla barra senza che lui neanche sappia il suo capo d’accusa, e destinato ad imparare sulla sua pelle che non c’è una vera accusa e forse neanche una vera condanna. Tra un capo e l’altro del Novecento però, il discorso che Kafka conduceva sulla responsabilità all’interno dei suoi tre romanzi e dei suoi più numerosi racconti viene di fatto ribaltato dal Kubrick di Eyes Wide Shut: in Kafka c’era la responsabilità senza colpa, in Eyes Wide Shut la colpa senza la responsabilità. Anzi, nell’opera postuma di Kubrick c’è un affidarsi ai poteri occulti che ormai sa reggere la società senza neanche più cercare di indagare, come spasmodicamente faceva Joseph K. almeno all’inizio del romanzo, circa il proprio destino.
Non è però solo un fatto repressivo-pulsionale a dare ad Eyes Wide Shut quel suo carattere “ultimativo” nei confronti della tradizione letteraria e cinematografica che l’aveva preceduto. È anche la sua trattazione della sessualità umana, a livello della rappresentazione prima ancora che di contenuto, a collocarsi lungo una genealogia di progressiva liberalizzazione dell’arte. La sessualità come libero oggetto d’arte e di narrazione fu parzialmente ma definitivamente sdoganata proprio dalla Lolita di Nabokov, pubblicata per la prima volta, dopo molte difficoltà, presso un editore parigino nel 1955. L’opera di Nabokov, che adesso ci appare relativamente innocua quanto a riferimenti “espliciti” del testo, venne alla luce negli stessi anni in cui, nell’industria cinematografica americana, vigeva il cosiddetto “Codice Hays”, atto a limitare e censurare quasi tutti gli atti di violenza, sessualità o criminalità presenti nelle pellicole, al quale lo stesso adattamento kubrickiano del romanzo dovette in parte adeguarsi: ma, sull’onda della rivoluzione sessuale, a partire dagli anni settanta, con opere quali Easy Rider, Il laureato, Un uomo da marciapiede, Ultimo Tango a Parigi e la stessa Arancia Meccanica fu gradualmente liberalizzata anche nel cinema la rappresentazione esplicita del consumo della droga, del sesso e della violenza. Eyes Wide Shut, con i suoi spinelli e le sue orge, si colloca alla fine di un processo iniziato tre decenni prima, che, a ridosso del nuovo millennio, avrebbe permesso a due acclamate star hollywoodiane di prendere ben volentieri parte a quello che era presentato come un “thriller erotico” di un grande autore del cinema statunitense.
Sarebbe tuttavia riduttivo vedere Eyes Wide Shut come semplice punto d’arrivo o “tappa” di questo percorso di liberazione dell’arte e dei costumi. Rispetto all’indagine sulla sessualità condotta nel corso del Novecento, Eyes Wide Shut ritorna al punto di partenza, la psicoanalisi freudiana, per fare luce su tutto ciò che era successo in quest’ambito nel corso del Novecento – e su come tutte le conquiste di metà secolo stessero di fatto cambiando la società molto più lentamente di quanto si potesse chiedere. Dopo l’euforia del Sessantotto e la sensualità “naturalistica” di Ultimo tango, dopo il leggiadro e perturbante insinuarsi della sessualità di Basic Instinct, l’opera ultima di Kubrick appare inevitabilmente come quello che si dice una doccia fredda – uno sguardo freddo, distaccato, forse cinico sui rapporti interpersonali e sulla sessualità di coppia. In Eyes Wide Shut, la sessualità è ridotta a quello che effettivamente è, a un livello strutturale: rapporti sessuali meccanici ai limiti della perversione, nella ricerca affannosa di un coito “a una dimensione”, di un piacere puramente personale, anche nelle relazioni matrimoniali. L’erotismo, inteso come sensualità, è solo una sovrastruttura, un codice di linguaggio non verbale resosi necessario in una società che, per “buon gusto” o educazione, insegna a nascondere la sessualità al di fuori di quelle elaborazioni discorsive di foucaultiana memoria (al medico, allo psicoanalista o al confessore). Eyes Wide Shut rappresenta una sessualità nuda e cruda, fin troppo cruda perché un semplice moviegoer potesse apprezzare il film, una sessualità tutt’altro che “sexy”, anzi assai fredda e pronta a dividere, più che a unire, uomo e donna.

Disegno originale © Elisa Terranera
È proprio la donna ad essere la “causa scatenante” dell’intero film, la donna e la sua inaspettata carica erotica. Il Novecento, già prima del femminismo e della liberazione sessuale, aveva subito questa scoperta: in modi diversi ma complementari Schnitzler, Joyce, Proust e lo stesso Salinger avevano saputo rappresentare con sincera precisione quell’”esitazione” del maschile dinnanzi all’emergere (o forse al fuoriuscire) di un femminile dotato di una sessualità propria, non più mero oggetto del desiderio. Certo, le narrazioni che compongono il canone della letteratura novecentesca europea rimangono per un’amplissima misura “maschili”, a firma di scrittori che trattano apertamente e francamente il maschile e più saltuariamente il femminile: nello stesso Eyes Wide Shut, per quanto sia Alice a reggere le dinamiche della coppia e a sancire l’inizio e la fine della loro crisi, resta pur sempre Bill a reggere le dinamiche del film – eppure non è priva di significato e di implicazioni questa presa d’atto di un femminile emergente e sempre più sovrano.
La grandezza di Eyes Wide Shut consiste proprio nel suo essere crocevia. Crocevia di temi, crocevia di archetipi, crocevia di sguardi, crocevia di sensi. Come ogni opera ultima e opera postuma, Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick assorge inevitabilmente ad essere una sorta di testamento artistico, anche se queste non erano le sue intenzioni; e in questa drammatica, a volte straziante storia di coppia, risiede il messaggio finale lasciato da Kubrick al mondo. Artista chiave, che ci piaccia o no, del Novecento, Stanley Kubrick, al pari di John Huston e dello stesso Bergman, alla fine della sua carriera parla per la prima volta di amore, di matrimonio, di fedeltà e di intimità: mantiene il suo sguardo, e mantiene il suo cuore – mantiene la sua lucidità, e il suo sguardo attento sull’uomo e sul mondo. E con un valzer di Shostakovich si chiude una carriera e una vita.
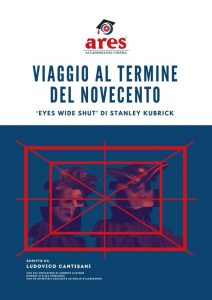
Viaggio al termine del Novecento
Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick
Ludovico Cantisani
disegni originali di Elisa Terranera
Accademia del Cinema UniARES
Pagine: 242
Pubblicazione: 2021
Prezzo: 18 euro



